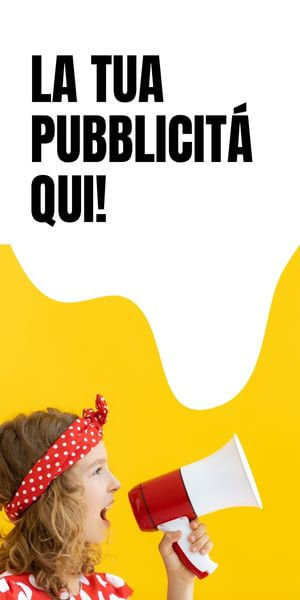Sardegna terra meravigliosa, ricca non solo di funghi ma anche di tartufi.
Funghi ipogei spontanei che vengono raccolti con una tecnica chiamata “Cerca e cavatura”, che il 16 dicembre 2021 è stata è anche maggiormente valorizzata e tutelata, con l’iscrizione nella lista UNESCO del Patrimonio culturale immateriale.
Un patrimonio collettivo e prezioso anche per le generazioni future, che va ben oltre il valore del prodotto in sé.
In Sardegna, unica regione nel panorama italiano, possiamo vantare anche l’antichissima pratica della cerca delle Terfezie, altra tipologia di funghi ipogei e, più recentemente, la cerca e raccolta dei tartufi e, seppur partiti in ritardo rispetto ad altre regioni italiane, sempre con il sistema di ricerca tradizionale con i cani, stiamo velocemente recuperando il gap preesistente.
La cerca delle Terfezie è una pratica tradizionale antichissima, con le prime notizie scientifiche ufficiali risalenti al 1829, da parte del Moris, che pubblica il Tuber arenarium, oggi Terfezia arenaria, a cui è seguita un’altra pubblicazione, nel 1887 da parte del Mattirolo, per il Coeromyces magnusii, oggi conosciuta come Terfezia magnusii.
Infatti, fino a qualche anno fa, gli unici funghi ipogei conosciuti in Sardegna e solo in alcune zone quali il Campidano di Oristano, l’Arburese, l’Iglesiente, la Piana di Chilivani e nelle coste Nord-Ovest del Sassarese, erano le Terfezie o “tartufi delle sabbie”, in sardo Tufara de arena.
Pratica di cerca e cavatura ancora presente ai giorni nostri, con le Terfezie che vengono ricercate, prevalentemente, per consumo personale e solo più raramente per commercio.
Attualmente, con la nascita, nel 2017, dell’Associazione Tartufai della Sardegna intestata a Paolo Fantini, con sede a Laconi, patria regionale del tartufo, con l’aggregazione di soci da tutta la regione c’è stata una sempre maggior crescita sulla conoscenza del prodotto e sua ricerca in tutto il territorio regionale. La finalità, tra l’altro, è quella di approfondire la conoscenza e la distribuzione delle specie ipogee e difendere e valorizzare il patrimonio tartufigeno sardo.
Il forte interesse per questi funghi ipogei sta coinvolgendo sempre più appassionati, giovani e meno giovani, specialmente nelle aree più vocate quali il Sarcidano, i vari Supramonte di Oliena, Orgosolo, Dorgali, Baunei, Urzulei; la subregione della Nurra e del Sassarese, le aree calcaree della Baronia.
A causa dell’isolamento geografico naturale della Sardegna, gli esperti ritengono che al momento il territorio sardo non sia “inquinato” da tartufi d’oltremare e che questo sia un elemento fondamentale per una sempre maggior valorizzazione del tartufo sardo. Infatti ad eccezione del Tuber magnatum pico (tartufo bianco) in Sardegna troviamo tutte le altre varietà, dal Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato al Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo estivo o scorzone, al Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo, proprio a dimostrazione della ricchezza di questo prodotto nella nostra terra.
Cerca e cavatura che devono avvenire nel pieno rispetto ambientale e senza danneggiare minimamente l’habitat, da cui la sempre maggior richiesta di vari Sindaci, di una regolamentazione legislativa a livello regionale.
Habitat che viene rispettato, senza intaccare radici od altro, utilizzando il cane e gli attrezzi idonei quali il vanghetto, lo zappetto ed il raspino.
Naturalmente tutte le razze canine sono buone, anche se sta avendo un successo sempre maggiore il “Lagotto Romagnolo”, ma l’importante è che abbiano un olfatto estremamente sviluppato, la sintonia col padrone e un opportuno addestramento, che deve iniziare nei primi mesi di vita.
Sfortunatamente in Sardegna non c’è ancora una Legge Regionale sui funghi ipogei o sui tartufi ed il riferimento è quello nazionale, con la Legge 16 dicembre 1985, n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/12/21/085U0752/sg
Esiste solamente un Proposta di Legge, la PL 168/A, per la “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale“ ferma dal 10/03/2021, presso la V Commissione permanente – Attività produttive https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/progetti-legge/168/
Si tratta di una proposta che la Commissione ha notevolmente migliorato, rispetto alla bozza iniziale, ma che presenta alcuni errori di fondo.
La cerca e cavatura del tartufo è molto dualistica. Inizialmente viene considerata come attività ambientale, almeno per la raccolta spontanea e poi, all’art, 6, comma 3 della PL168/A, la si riconosce come attività primaria, per cui agricola e produttiva, per poi delegare la gestione del tutto all’Assessorato all’Ambiente, che non ha assolutamente competenze sulle attività imprenditoriali nel settore primario, che invece spettano all’Assessorato all’Agricoltura.
Infatti, in tutta Italia, la cerca e la cavatura del tartufo è ovunque riconosciuta come attività primaria, come ricordato anche dalla stessa PL168/A all’art. 6 comma 3.
Sono evidenti delle contraddizioni palesi, come la tartufaia naturale controllata, che alla lettera g, è oggetto di gestione da parte di un imprenditore mentre la tartufaia coltivata, come da definizione nella PL168 all’art 2, lettera h, è una coltura agraria.
Ossia stiamo a parlare di attività imprenditoriali e non ambientali, da cui la naturale collocazione è presso l’Assessorato all’Agricoltura e non all’Ambiente ed ecco perché sono stati, giustamente, recentemente presentati degli emendamenti specifici in V Commissione.
Ricordo anche la possibilità di utilizzo del Complemento di Sviluppo Rurale, ex PSR, che prevede per le attività imprenditoriali un aiuto in conto capitale per tipologie produttive del genere, possibilità fino a poco tempo fa esclusa!
Però, il non essere attività primaria gestita dall’Assessorato all’Agricoltura, farà in modo che la tartuficoltura venga automaticamente esclusa da qualsiasi intervento finanziario.
“C’è da considerare una netta differenza – precisa Enrico Lancellotti, Vice Presidente dell’Associazione Tartufai della Sardegna – tra la libera cerca, ossia la raccolta spontanea produzione di tartufi e la produzione di tartufi da impianti artificiali, anche se la libera cerca può in un certo senso intesa come attività produttiva. Lo era soprattutto in passato, ma attualmente sta sempre più diventando anche una attività ricreativa.
Quest’ultima accezione è molto importante perché aiuta ad avvicinare i cittadini alle zone rurali e porta le persone a vivere la campagna, pur non essendone i protagonisti come possono esserlo gli agricoltori.”
Si spera che questo vuoto normativo venga presto superato, anche grazie alla presenza di un agronomo sardo tra i cinque componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano nel “Comitato di coordinamento della cerca e cavatura del tartufo in Italia”
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato- regioni/sedute-2022/seduta-del-02032022/atti/repertorio-atto-n-26csr/
Bisognerà evitare, ancora una volta, con una celere approvazione di una Legge Regionale, di danneggiare l’habitat e cercare di valorizzare l’imprenditore agricolo, che è il vero guardiano del territorio.